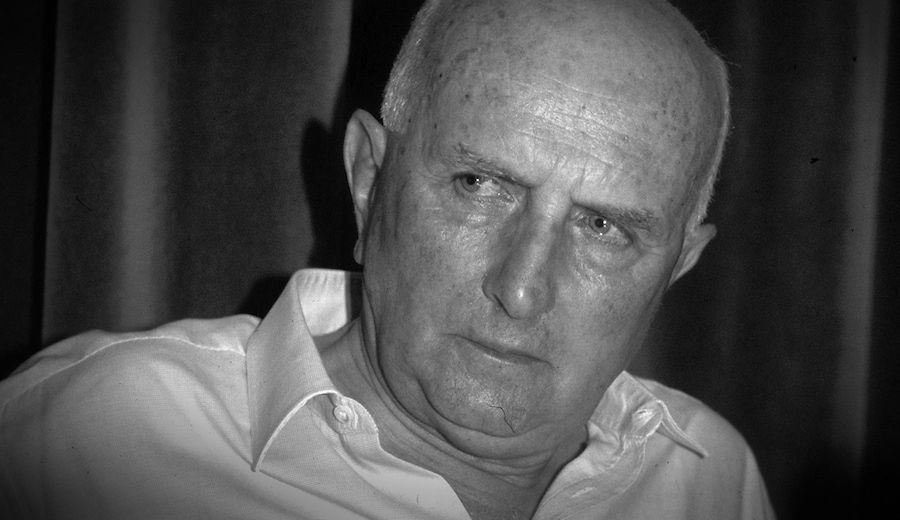Riccardo Bonacina ricorda Giovanni Testori
Intervista di Stas' Gawronski
Il direttore del settiamnale Vita, Riccardo Bonacina, in questa intervista di Stas' Gawronski, ricorda lo scrittore, drammaturgo e critico letterario Giovanni Testori.
Riccardo Bonacina è un giornalista che ha scelto di svolgere la propria professione in uno degli ambiti piú trascurati dai servizi di informazione, quello relativo al volontariato, al no-profit e ai piú deboli. Una scelta che nasce da una sensibilitá e da una visione del mondo che il giornalista ha condiviso con Giovanni Testori, come ci rivela in questa intervista.
Oggigiorno si ha la sensazione che sia sempre piú difficile sensibilizzare il pubblico sul disagio sociale attraverso la sola informazione. Non ti sembra che per coinvolgere la gente occorra tornare a “fare letteratura” ovvero a scrivere dei mali che affliggono gli ultimi non tanto puntando sulla precisione del dato, ma piuttosto sul potere di immedesimazione che un testo di narrativa può offrire?
”Sociale”, vi sembrerà strano per uno che se ne occupa e che lo racconta da più di dieci anni (ahimè), è una parola che non amo. Proprio Giovanni Testori, artista e intellettuale cui devo molto per l’affetto con cui incoraggiò ogni mio tentativo, diceva sempre il sociale non è mai un valore in sé, ma solo una dimensione della vita, della realtà, sociale è insomma un aggettivo seppur qualificativo, non è un sostantivo. Se diventa un sostantivo, un valore in sé, ammoniva Testori, si rischia, nella Chiesa un’eresia sociale, e nella vita politica il sociale diventa il nome e il luogo della manipolazione delle persone e dei loro desideri. “Eresia sociale”, è una definizione che non ho più scordato, che mi è rimasta in testa come categoria di discernimento, come paradigma di giudizio nel leggere le gazzette e abitare la babele d'oggi.
O che non va compiutamente. Cosa diciamo, infatti, quando nominiamo il sociale? Diciamo che la vita non finisce con noi, diciamo che non c’è avventura umana senza un vero e proprio ingresso in società. Di questo passaggio che nei secoli passati era ben definito e che aveva le sue liturgie oggi non ci rimangono che delle parodie. Ma la definizione mantiene una sua suggestione e ci aiuta a capire cosa sia la dimensione sociale. L’ingresso in società indica un’azione, un passaggio da una dimensione privata ad una pubblica, nomina il passaggio dall’io al noi. L’ingresso in società dice che la tua vita uscirà da una sfera prettamente privata per approdare ad una vita di relazioni, di relazione pubbliche. Oggi questo passaggio, questo rito non c’è più perché prima del nostro ingresso in società, la società è già entrata in noi, e ben prima che noi possiamo averne coscienza, ben prima che sia possibile stabile un nesso, una relazione tra l’io e la realtà. Oggi non c’è più un “io” che si presenta in società facendo il suo ingresso. Per questo penso che in cima ai nostri pensieri dobbiamo mettere la preoccupazione dell’io, della consistenza dell’io, e della possibilità di dire “tu” e perciò di stabilire una nuova relazione, una reciprocità. Senza questo, è vero quello che diceva Testori, il sociale è una prigione o un’eresia. Da questo punto di vista, è verissimo quello che tu dici, la letteratura può aiutare.
In questo senso, qual è l’insegnamento di Testori per un giornalista che come te si occupa di questioni sociali?
Testori diceva sempre che: "Basta amare la realtà, sempre in tutti i modi" . Questo nel mio lavoro è diventato un vero motto. Raccontare la realtà per immedesimazione, amandola, cercando di restituirle la parola, in mezzo ad una marmellata di clamori (questa è oggi l'informazione).
Testori accusava la società contemporanea di nascondere, in nome del benessere e dell’efficienza, il senso ultimo dell’esistenza umana e, venendo a mancare il senso, di impedire il sorgere nelle coscienze di una “legittima e sacrosanta rivolta”. Non credi che questa affermazione riguardi anche coloro che nel mondo del no-profit, pur proponendosi di cambiare il mondo, sono piú preoccupati dell’efficacia dei servizi che dell’approfondimento delle ragioni?
Dico sempre che uno dei rischi fondamentali del non profit è quello di "non pensare", c'è un deficit di pensiero sulle ragioni dell'impegno, di un impegno spesso così ammirevole, generoso, anche efficace. Bisogna, per non spegnere la sorgente della gratuità, approfondirne le ragioni, riflettere sulle esperienze sino a farne cultura.
C’è un’opera, tra quelle di Testori, che consiglieresti di leggere ad un lettore che si accosta per la prima volta alla produzione letteraria dello scrittore lombardo?
Io ho conosciuto Testori dopo aver letto un articolo, il suo articolo all'indomani del rapimento di Aldo Moro in via Fani. Dopo averlo letto (ero un giovane studente universitario) mi informai sul suo indirizzo, andai a suonare al campanello di via Brera 8 per dirgli grazie. Quell'articolo è raccolto, insieme a tutta la sua produzione giornalistica, nel libro La maestà della vita (Rizzoli). In questo periodo gli Oscar Mondadori hanno anche editato un bel libro che raccoglie tutto ciò che Testori ha scritto e detto su Manzoni (dalla Monaca di Monza al verbale della sua conferenza confronto con Moravia). Da leggere.
A dieci anni dalla morte, conosci uno o piú artisti che abbiano raccolto l’ereditá di Testori nella visione e nella capacità di rappresentazione della realtà degli ultimi?
Sono un'infinità gli artisti che lui ha lanciato o che ha influenzato: pittori, attori, scrittori, ma anche giornalisti. Oggi Testori è l'autore italiano contemporaneo più rappresentato, 15 compagnie lo hanno messo in scena, da Lombardi-Tiezzi a Ferdinando Bruni, da Maurizio Donadoni ad Antonio Latella. Attori che magari non lo hanno neppure conosciuto ma che lo scoprono oggi e dicono "Ma dopo Testori che posso fare?". Così è tra i pittori, c'è un'intera generazione di quarantenni che lui lanciò, da Giovanni Frangi a Velasco, da Rainer Fetting ad Alessandro Papetti. Tra gli scrittori, da Luca Doninelli a Raul Montanari.
Tu hai intervistato Testori pochi mesi prima della sua scomparsa. Che ricordo hai di quello specifico incontro?
Fu l'ultimo atto di un dialogo che iniziò nel 1978 e durò sino alla sua scomparsa il 16 marzo 1993. Quindici anni di amicizia con un maestro. Da questo punto di vista, pur nella sua eccezionalità, quell'intervista fu per me una cosa normale. A Roma in poche settimane erano stati uccisi 6 omosessuali. Chiamai Testori in ospedale per chiedergli "Mi aiuti a capire?".
Come ha influito la conoscenza di Testori nello sviluppo della tua visione della vita?
È stata più di un'influenza la sua, con lui ho vissuto 15 anni intensi di iniziative, dal settimanale Il Sabato, alla rivista Synesis, alla fondazione della Compagnia degli Incamminati, alle mostre, sino alla decisione del nome di un settimanale che avrebbe raccontato la Vita e non i pettegolezzi del potere. Un settimanale che è nato poco più di un anno dopo la sua morte, Vita, ma che è stato il suo ultimo regalo. Invitava sempre a non avere paura di fare, di rischiare, di mettersi in gioco perché la vita è data per questo.
Riccardo Bonacina è un giornalista che ha scelto di svolgere la propria professione in uno degli ambiti piú trascurati dai servizi di informazione, quello relativo al volontariato, al no-profit e ai piú deboli. Una scelta che nasce da una sensibilitá e da una visione del mondo che il giornalista ha condiviso con Giovanni Testori, come ci rivela in questa intervista.
Oggigiorno si ha la sensazione che sia sempre piú difficile sensibilizzare il pubblico sul disagio sociale attraverso la sola informazione. Non ti sembra che per coinvolgere la gente occorra tornare a “fare letteratura” ovvero a scrivere dei mali che affliggono gli ultimi non tanto puntando sulla precisione del dato, ma piuttosto sul potere di immedesimazione che un testo di narrativa può offrire?
”Sociale”, vi sembrerà strano per uno che se ne occupa e che lo racconta da più di dieci anni (ahimè), è una parola che non amo. Proprio Giovanni Testori, artista e intellettuale cui devo molto per l’affetto con cui incoraggiò ogni mio tentativo, diceva sempre il sociale non è mai un valore in sé, ma solo una dimensione della vita, della realtà, sociale è insomma un aggettivo seppur qualificativo, non è un sostantivo. Se diventa un sostantivo, un valore in sé, ammoniva Testori, si rischia, nella Chiesa un’eresia sociale, e nella vita politica il sociale diventa il nome e il luogo della manipolazione delle persone e dei loro desideri. “Eresia sociale”, è una definizione che non ho più scordato, che mi è rimasta in testa come categoria di discernimento, come paradigma di giudizio nel leggere le gazzette e abitare la babele d'oggi.
Il sociale non è un valore in sé ma una dimensione della nostra vita, mi sembra importante sottolineare questo in un periodo in cui si tende ad enfatizzare il sociale, dalla politica al business come se esso fosse il valore, lo scopo. C’è qualcosa che non quadra, che non va.
O che non va compiutamente. Cosa diciamo, infatti, quando nominiamo il sociale? Diciamo che la vita non finisce con noi, diciamo che non c’è avventura umana senza un vero e proprio ingresso in società. Di questo passaggio che nei secoli passati era ben definito e che aveva le sue liturgie oggi non ci rimangono che delle parodie. Ma la definizione mantiene una sua suggestione e ci aiuta a capire cosa sia la dimensione sociale. L’ingresso in società indica un’azione, un passaggio da una dimensione privata ad una pubblica, nomina il passaggio dall’io al noi. L’ingresso in società dice che la tua vita uscirà da una sfera prettamente privata per approdare ad una vita di relazioni, di relazione pubbliche. Oggi questo passaggio, questo rito non c’è più perché prima del nostro ingresso in società, la società è già entrata in noi, e ben prima che noi possiamo averne coscienza, ben prima che sia possibile stabile un nesso, una relazione tra l’io e la realtà. Oggi non c’è più un “io” che si presenta in società facendo il suo ingresso. Per questo penso che in cima ai nostri pensieri dobbiamo mettere la preoccupazione dell’io, della consistenza dell’io, e della possibilità di dire “tu” e perciò di stabilire una nuova relazione, una reciprocità. Senza questo, è vero quello che diceva Testori, il sociale è una prigione o un’eresia. Da questo punto di vista, è verissimo quello che tu dici, la letteratura può aiutare.
In questo senso, qual è l’insegnamento di Testori per un giornalista che come te si occupa di questioni sociali?
Testori diceva sempre che: "Basta amare la realtà, sempre in tutti i modi" . Questo nel mio lavoro è diventato un vero motto. Raccontare la realtà per immedesimazione, amandola, cercando di restituirle la parola, in mezzo ad una marmellata di clamori (questa è oggi l'informazione).
Testori accusava la società contemporanea di nascondere, in nome del benessere e dell’efficienza, il senso ultimo dell’esistenza umana e, venendo a mancare il senso, di impedire il sorgere nelle coscienze di una “legittima e sacrosanta rivolta”. Non credi che questa affermazione riguardi anche coloro che nel mondo del no-profit, pur proponendosi di cambiare il mondo, sono piú preoccupati dell’efficacia dei servizi che dell’approfondimento delle ragioni?
Dico sempre che uno dei rischi fondamentali del non profit è quello di "non pensare", c'è un deficit di pensiero sulle ragioni dell'impegno, di un impegno spesso così ammirevole, generoso, anche efficace. Bisogna, per non spegnere la sorgente della gratuità, approfondirne le ragioni, riflettere sulle esperienze sino a farne cultura.
C’è un’opera, tra quelle di Testori, che consiglieresti di leggere ad un lettore che si accosta per la prima volta alla produzione letteraria dello scrittore lombardo?
Io ho conosciuto Testori dopo aver letto un articolo, il suo articolo all'indomani del rapimento di Aldo Moro in via Fani. Dopo averlo letto (ero un giovane studente universitario) mi informai sul suo indirizzo, andai a suonare al campanello di via Brera 8 per dirgli grazie. Quell'articolo è raccolto, insieme a tutta la sua produzione giornalistica, nel libro La maestà della vita (Rizzoli). In questo periodo gli Oscar Mondadori hanno anche editato un bel libro che raccoglie tutto ciò che Testori ha scritto e detto su Manzoni (dalla Monaca di Monza al verbale della sua conferenza confronto con Moravia). Da leggere.
A dieci anni dalla morte, conosci uno o piú artisti che abbiano raccolto l’ereditá di Testori nella visione e nella capacità di rappresentazione della realtà degli ultimi?
Sono un'infinità gli artisti che lui ha lanciato o che ha influenzato: pittori, attori, scrittori, ma anche giornalisti. Oggi Testori è l'autore italiano contemporaneo più rappresentato, 15 compagnie lo hanno messo in scena, da Lombardi-Tiezzi a Ferdinando Bruni, da Maurizio Donadoni ad Antonio Latella. Attori che magari non lo hanno neppure conosciuto ma che lo scoprono oggi e dicono "Ma dopo Testori che posso fare?". Così è tra i pittori, c'è un'intera generazione di quarantenni che lui lanciò, da Giovanni Frangi a Velasco, da Rainer Fetting ad Alessandro Papetti. Tra gli scrittori, da Luca Doninelli a Raul Montanari.
Tu hai intervistato Testori pochi mesi prima della sua scomparsa. Che ricordo hai di quello specifico incontro?
Fu l'ultimo atto di un dialogo che iniziò nel 1978 e durò sino alla sua scomparsa il 16 marzo 1993. Quindici anni di amicizia con un maestro. Da questo punto di vista, pur nella sua eccezionalità, quell'intervista fu per me una cosa normale. A Roma in poche settimane erano stati uccisi 6 omosessuali. Chiamai Testori in ospedale per chiedergli "Mi aiuti a capire?".
Come ha influito la conoscenza di Testori nello sviluppo della tua visione della vita?
È stata più di un'influenza la sua, con lui ho vissuto 15 anni intensi di iniziative, dal settimanale Il Sabato, alla rivista Synesis, alla fondazione della Compagnia degli Incamminati, alle mostre, sino alla decisione del nome di un settimanale che avrebbe raccontato la Vita e non i pettegolezzi del potere. Un settimanale che è nato poco più di un anno dopo la sua morte, Vita, ma che è stato il suo ultimo regalo. Invitava sempre a non avere paura di fare, di rischiare, di mettersi in gioco perché la vita è data per questo.